“… Il libro non è un romanzo, né un trattato di cetologia. È qualcosa di entrambi: uno strano lavoro selvaggio con la vegetazione intricata e rigogliosa delle foreste americane, e non l’ordine di un parco inglese curato. La critica può cogliere molti buchi in questo lavoro; ma nessuna critica ne ostacolerà la fascinazione.”
– London Leader, 8 novembre 1851
Quando un libro continua a riemergere, soprattutto se sono passati molti anni, è il momento di tonarci su. Ma una lettura come Moby Dick non è impresa facile. Sarò sincero: avevo letto per prima una sua riduzione per ragazzi, a scuola, poi a venticinque anni avevo affrontato l’edizione integrale. Saltando fior di paragrafi. All’epoca, tra gli altri, leggevo Thomas Mann, Stendhal, Dostoevskij e Shakespeare. Chissà cosa ci capivo, nessuno di loro era di facile lettura, ma Moby Dick…
Recentemente scopro che è nelle corde più profonde di Sepùlveda e del Capitano Watson di Sea Shepherd. Entrambi, in un modo o nell’altro, si identificano con la balena bianca. Ma è lo scrittore Sepùlveda a dedicare al tema almeno due romanzi e parte della sua vita come attivista di Greenpeace. La tentazione è quella di rileggerlo in lingua originale, ma poi mi dico: cosa può pretendere il mio immaginario italofono per non affidarsi a un Cesare Pavese? Moby Dick, stavolta, mi guarda dalla libreria della mia compagna. Lo apro: è quasi intatto, non una ruga sulla costa. Capisco.
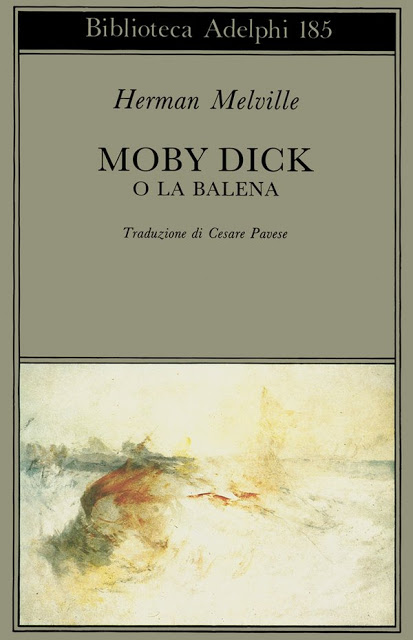
Achab nell’immaginario collettivo.
Moby Dick è un’opera ponderosa, 588 pagine nell’edizione Adelphi, ma quello che è entrato nell’immaginario quasi come un moderno archetipo è riassumibile nelle prime cinquanta e nelle ultime venti pagine. Ciò non rende giustizia a questo ‘strano lavoro selvaggio’, che è insieme un saggio, un romanzo di mare, una tragedia shakespeariana, una commedia brillante, una pièce teatrale e un noir psicologico, il tutto narrato con tono prevalentemente biblico. Un editor moderno griderebbe: ‘Troppa carne al fuoco!’. Mi domando, come scrittore, cosa avesse pensato davvero e quanto avesse influito Nathaniel Hawthorne, levatrice in questo parto, su un’opera così audace, a tratti lugubre, a volte brillante, decisamente affastellata.
Purtroppo non ci è dato a sapere. Resta, semmai, una interessante investigazione per una fiction storico-letteraria. Mentre mi pongo domande senza risposta il taglio hollywoodiano ha preso il sopravvento: Achab, personaggio chiave,è un uomo posseduto, un uomo quasi senza sfumature nel perfetto stile dicotomico di chi vuole dare risposte semplici a domande complesse. Nel romanzo Achab sembra un povero diavolo, triste e solitario. Un tipo grigio, capace solo nel suo mestiere e con un decente, ma incompleto, ascendente sugli altri. Achab è il prototipo psicologico dello ‘sparatore’ (shooter) americano, un fallito che un giorno uccide i dipendenti dell’azienda che lo ha licenziato. Un uomo che ha subito un torto e medita vendetta. Il suo nemico è la balena bianca che gli ha portato via una gamba. Non esita a trascinare l’intero equipaggio alla distruzione in un lento percorso verso un delirio sommesso. Il delirio accelera quando lui decide di ignorare una richiesta di soccorso dalla ‘Rachel’, una nave che ha perso parte del suo equipaggio (i suoi figli) in mare con le lance, durante una battuta di caccia. Ed è lì che Achab si danna. Si danna ignorando i presagi del marinaio persiano, si danna nel pieno esercizio del suo libero arbitrio. Nello scegliere la vendetta ad un atto umanitario egli disprezza il codice d’onore della marineria e accoglie in sé, già avvertito da innumerevoli presagi, la dannazione degli dei. Abbandonare chiunque in mare, va purtroppo ricordato in questi tempi, per un marinaio è il peccato più infamante. Ce lo rammenta Conrad in Lord Jim, forse il suo dramma più grande e complesso.
Perché Moby Dick è considerato il più grande romanzo della letteratura americana.
La letteratura americana ha prodotto opere immense, da far impallidire l’Europa moderna, è quindi lecito chiedersi come mai un libro lento, elaborato all’eccesso, fitto di reiterazioni, sia considerato tale. La risposta è semplice: c’è dentro il DNA del romanzo moderno, c’è l’erudizione scientifica (riferita ai tempi e con qualche ingenuità) c’è dentro un equipaggio che rappresenta tutti i continenti e le etnie conosciute del globo più un nativo americano, nel perfetto mito dell’inclusività,. Il Pequod, la nave baleniera di Moby Dick, è il famigerato melting pot. C’è dentro il sogno americano con tutti i suoi orizzonti e le sue tragedie, decise da uomini tristi ma volitivi che condannano a morte altri uomini e loro stessi nel nome di una parossistica competizione. Ci sono il mito, la bibbia e la psicologia. Non ultimo, si presta a innumerevoli livelli di lettura. Moby Dick, rispetto a un romanzo di un Umberto Eco, non si è lasciato dietro niente. Semmai ha esagerato nel bagaglio. Con indulgenze che remano contro la scorrevolezza. Solo che Hermann Melville c’era davvero. La sua forza è quella dell’autore moderno: la vita dell’autore autorizza il romanzo. Immagino lo stesso manoscritto nelle mani di uno Steinbeck o di un Hemingway o di un Truman Capote come editor. In trecento pagine, non una di più, avremmo lo stesso effetto, senza un minimo di fatica. Non sorprende troppo che Moby Dick fu un fiasco totale. L’opera fu recuperata settanta anni dopo.
Fu colpa di Hawthorne? Di nuovo: non possiamo saperlo. Sappiamo che fino a Moby Dick Melville fu uno scrittore dal discreto successo e che, sostenuto da Hawthorne, si cimentò in un’opera che nella letteratura italiana potremmo paragonare a un Horcynus Orca (altro capolavoro che ho lasciato a metà e che, giuro, rileggerò).
NB: come recensore sono affidabile solo fino a un certo pubblico. Per quanto ci abbia provato tantissime volte in Inglese e in Italiano, non sono mai riuscito ad amare/capire Joyce. Confesso di avere lo stesso limite col jazz. I miei limiti hanno trovato la pace in una massima di V.S. Naipaul
Vorrei una prosa trasparente, non voglio che il lettore inciampi su di me; voglio che lui veda attraverso le mie parole ciò che sto descrivendo. Non voglio che lui dica “Oh, santo cielo, com’è scritto bene!”: sarebbe un fallimento.
Uno scrittore costruisce mondi
In questo Melville riesce benissimo. Ci porta nel mondo della gente di mare, dei balenieri, e dell’ironia spocchiosa e incredula che la gente di mare riversa sulla gente di terra. Soprattutto se prima di imbarcarsi si è fatto altro. Nella descrizione di New York, alle prime pagine, ho visto me stesso, consapevole che la vita in mare è un viaggio senza ritorno. L’elegia alla vita in mare è la circolazione sanguigna del romanzo. Leggendolo si è marinai, si è balenieri, si è reietti e avventurieri su legni coi quali non usciremmo una domenica pomeriggio su un lago in assenza di vento. Era un mestiere da pazzi.
C’è il matrimonio tra il narratore e il selvaggio Quiqueg, che viene sottolineato spesso, ma che la voce narrante presenta come un esotismo, vissuto quasi da goliardata. Quiqueg nell’opera quasi scompare, per riapparire verso la fine in una esilarante scena in cui tutti lo danno per morto, tanto da costruirgli la bara, e lui si rialza dal letto come se niente fosse. Ma i migliori tra i mondi fittizi affondano le radici nella realtà. Il cuore pulsante di Moby Dick attinge da uno dei fatti più strani nella storia della marineria: l’affondamento dell’Essex, nel 1821, ad opera di una balena bianca al largo di Mocha, un’isola del Cile, da cui Mocha Dick e poi: Moby Dick.
Retaggio ecologico
Melville, da uomo di mare capace di acuta osservazione, sa che gli squali non attaccano i marinai se non per sbaglio o quando sono eccitati, ma si riferisce a balene e capodogli più spesso come mostri, o leviatani. Allo stesso tempo descrive la biologia dei grandi cetacei (con le cognizioni limitate dell’epoca) e le loro pene con una pietà rarissima, da vero innamorato delle specie. Ma l’identificazione tra la preda e il cacciatore è un fatto antico, lo sappiamo, e Melville va oltre: dedica alla preda quasi più pagine che all’epica del cacciatore. Intravvediamo la regola per cui la grandezza dell’eroe è pari alla grandezza del villain. Moby Dick, unica tra le balene, ha il privilegio e la statura di un cattivo di Bond. Melville ci dice, neanche troppo velatamente, che uccidere balene è uccidere esseri ‘superiori’. La ripugnanza ad uccidere, la ripugnanza per questa sorta di corrida, è palpabile in tutta la narrazione, tanto che a tratti sembra di leggere un mea culpa.
Il lecito dubbio è che si tratti soltanto un espediente drammatico. Le sue considerazioni sull’abbondanza delle specie marine, nel contesto, sono quelle di un odierno rivenditore di prodotti di medicina tradizionale cinese: ‘La natura è grande, non finirà mai le sue scorte’ Ma involontariamente Melville, grazie al senno dei posteri, ci sbatte in faccia la nostra svista più colossale: bisonti e balene furono gettati sull’orlo dell’estinzione proprio per questo concetto. La risposta di Melville è quasi ininfluente rispetto alla domanda: quello che conta è che lui, eroico baleniere del diciannovesimo secolo, quella domanda se l’era posta davvero. Nella balena bianca e nei dettagli disseminati si leggono già a chiare lettere due dinamiche moderne: la vendetta della natura ferita e l’ossessione di una specie che vuole domare la natura al costo di distruggere se stessa. La nostra.
Genesi e Nemesi d’un capolavoro.
Melville era un uomo di cultura. Nessuno si aspettava, centosettanta anni fa, che un marinaio baleniere conoscesse il mito e la storia antica, pur se citati aneddoticamente. Tantomeno che si intendesse di etologia, biologia e di anatomia dei cetacei, anche se per uno sguardo diretto ed istruito etologia e anatomia ci stanno eccome. Purtroppo per molti versi, visto lo sfoggio di erudizione, la costruzione complessa delle frasi e della storia, un capolavoro come Moby Dick sembrò un romanzo artificioso, tanto da apparire fittizio allo scrittore di mare che ritengo il più grande di tutti i tempi.
“Anni fa ho esaminato Typee e Omoo , ma siccome non ho trovato quello che cercavo, non sono andato oltre. Ultimamente avevo in mano Moby Dick . Mi colpì come rapsodia piuttosto tesa, con la caccia alle balene come soggetto, ma non una singola riga sincera.”
Joseph Conrad a Humphrey Milford, 15 gennaio 1907
Mi guardo bene dall’attribuire stellette ad un’opera come Moby Dick. C’è gente che recensisce su Trip Advisor Piazza San Pietro e i Musei Vaticani, e non voglio minimamente assomigliare a quella risma. Mi rifaccio alle critiche autorevoli che ho citato: il Leader di Londra e Joseph Conrad, nelle quali, soprattutto la prima, mi riconosco un po’. Moby Dick resta un romanzo seminale, imprescindibile per chiunque legga, o scriva, di mare.
Per approfondire:
http://www.melville.org/download.htm
storia di una balena bianca raccontata da lei stessa.htm
l‘irriducibile capitano watson/
Se ti piace ciò che leggo e ciò che ne penso c’è la possibilità che ti piaccia ciò che scrivo
Qui trovi i miei lavorihttps://claudiodimanao-libri




















