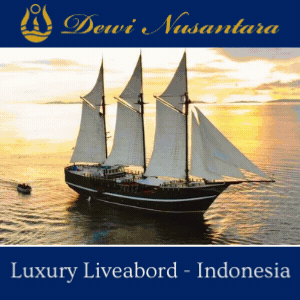Autore: Claudio Corti
In quella giornata di agosto eravamo, dunque, alla ricerca del relitto della motonave "Washington". Quando fummo sulle mire forniteci dal vecchio marinaio di Camogli, dopo una ricerca neppure troppo difficile ecco che sulla carta del nostro ecoscandaglio comparve una massa scura notevole, che da un fondo di circa -86 metri saliva sino a -76 metri.

Al secondo passaggio lanciammo il pedagno, lungo il cui cavo ci saremmo immersi, e iniziammo la vestizione. Quando tutto fu pronto, e dopo aver ancorato in modo sicuro la barca nelle vicinanze del relitto, raggiungemmo a nuoto la boa del pedagno e quindi iniziammo la lunga discesa verso il fondo seguendo la sagola bianca che si perdeva nel blu cupo dell’alto fondale.
Sino a 50 metri la visibilità era ottima, l’acqua era calda e pulita Ma sotto i 50 la situazione peggiorò: più scendevamo, più l’acqua diventava torbida. Dopo quattro minuti, avendo rallentato la velocità di discesa a causa dell’assoluta mancanza di visibilità, arrivammo sul fondo.
L’Aladin di Damiano segnava -85, la lancetta del mio profondimetro si era invece fermata a -83. A quell’epoca, erano pochi i sommozzatori sportivi che si immergevano a quelle profondità. Oggi con il Trimix è diverso, perchè sappiamo che un bravo subacqueo può, dopo uno specifico addestramento, giungere a quelle quote. Ma allora la subacquea tecnica non era ancora diffusa.
Attorno a noi non si scorgeva nulla, solo fango. Le sensazioni giungevano alla mia mente come ovattate, le mie risposte erano lente, la narcosi a quella quota era veramente elevata. Evidentemente avevamo sbagliato a gettare il pedagno: dove era il relitto? Legammo il sagolino del mulinello (quelli per pesca subacquea) al piombo del pedagno e ci allontanammo un poco per vedere se si trovava la nave. Il tempo scorreva veloce e noi, non vedendo nulla, pinneggiavamo piano piano, tenendo la maschera a soli 20 o 30 centimetri dal fondo, ove crescevano alcuni alcionari, detti Mani di Morto, che nello stato d’animo in cui ci trovavamo facevano proprio impressione per via, più che dell’aspetto, del nome inquietante. Finalmente, dopo qualche secondo che parve un’eternità, intravedemmo una piccola parte di un corrimano di ferro. Eravamo arrivati al relitto. Ma un’occhiata al manometro dell’aria, che continuava la sua rapida discesa verso il fondo scala, al decimo minuto ci consigliò di tornare velocemente al pedagno per iniziare la risalita. A 50 metri ci sembrò di lasciare il mondo delle tenebre e di tornare nel mondo della luce. Dopo la decompressione, riemergemmo un poco delusi: del relitto, in pratica, avevamo visto solo un pezzo di ferro.
Quando salpammo il pedagno, mi resi conto che avevamo mancato la nave a causa di una errata valutazione da parte nostra della traccia dell’ecoscandaglio, che, essendo uno strumento sofisticato, nato per un uso professionale e adatto alla pesca in alto mare, rilevava un’ampia zona del fondo, segnalando la presenza del relitto anche se non eravamo ancora giunti sulla sua perfetta verticale. «Peccato, – dissi a Damiano, – sarà per domani». E difatti il giorno dopo ci riportammo sul punto ormai certo. Il "Washington" apparve sull’ecoscandaglio e noi lanciammo in mare il pedagno che ci avrebbe guidato ancora una volta nella discesa. Prima di scendere in acqua, però, effettuammo un paio di passaggi sulla verticale e, ormai sicuri che il pedagno fosse finito proprio sui resti del piroscafo, iniziammo i preparativi per l’immersione. Controllammo l’aria nelle bombole: io avevo sulle spalle 5.280 litri di aria, mentre Damiano, nella bombola caricata a 250 bar, ne aveva 4.725 litri.


Durante la discesa lasciammo alcuni mono legati lungo la cima: ci potevano servire in decompressione durante un’emergenza. Come il giorno prima, l’acqua era limpida sino a 50 metri, poi diventava torbida. Giungemmo sul fondo vicino alla murata di sinistra del bastimento. La prua è rivolta verso Nervi e lo scafo è ridotto a un ammasso informe di rottami, un guscio vuoto e irriconoscibile. Ricordo che quel giorno una simile constatazione mi strinse il cuore. Chissà che cosa speravo di vedere, dato che conoscevo già la storia di quella nave.
Il giorno successivo si alzarono vento e mare da scirocco. Le vacanze volgevano al termine e le previsioni erano brutte. Così decidemmo di rimandare il seguito delle esplorazioni a momenti migliori. Momenti che, per le vicende della vita, si presentarono parecchi anni dopo: i miei compagni di avventura erano cambiati. Nel 1993 venne con me Stefano Casartelli, esperto subacqueo di Villa Guardia a cui avevo spiegato le tecniche del Trimix; nel 1998 vennero Aldo Bimbato, di Torino, anch’egli mio allievo in un corso di istruttore Trimix, e Jean Pierre Aschieri, di Marsiglia, un allievo istruttore Trimix della T.S.A., la didattica tecnica che presiedo. Naturalmente, non usavamo più l’aria, ma una miscela Trimix contenente un’alta percentuale di elio. Anche se erano passati parecchi anni dalle prime immersioni sul "Washington", la ricerca del relitto non fu mai un problema, perchè ormai avevo nel mio Gps le coordinate esatte del punto in cui si trova. Come di abitudine, ormai, sono sempre stato ben attento al momento in cui buttare il pedagno e ho sempre centrato il bersaglio al primo colpo.
Le discese erano sempre veloci, dato che eravamo tutti subacquei esperti di questo tipo di immersioni. All’oscurità dei fondali liguri ci eravamo, d’altronde, abituati. Raggiungemmo la nave sempre attorno ai -78 metri, poi scendemmo tutte le volte sino sul fondo, a -85: la visibilità era pessima e le foto che ho scattato nelle varie occasioni in cui mi sono trovato hanno sempre mostrato molta sospensione.
Due anni dopo, Michele Calabrese, che nel frattempo aveva acquistato la mia barca, mi invitò a fare un’immersione profonda in Trimix. Gli dissi: «Va bene, ma andiamo sul "Washington"». Lui accettò volentieri, anche perchè non conosceva questo relitto e non aveva i punti. Ci immergemmo in una triste giornata autunnale del 2000, il sole era nascosto dalle nubi: le previsioni, che il giorno prima ci sembravano buone, ci avevano tradito. Così, come tutte le altre volte, l’acqua sotto i 50 metri era torbidissima. La visibilità era di un metro. Inoltre, dato che il cielo era coperto dalle nuvole, la luce era ancora più scarsa delle altre volte. Senza allontanarci dalla catena dell’ancora, che Michele aveva voluto gettare di traverso sul relitto, arrivammo prima sul ponte, poi scendemmo lungo la fiancata sino al fondo, a -85 metri. Data la scarsissima visibilità, non osammo allontanarci molto dalla catena e dopo 15 minuti di fondo iniziammo la risalita. Michele era soddisfatto per aver potuto localizzare il relitto, io invece, presumendo di avere consumato un altro rullino per nulla, molto di meno.
Pochi mesi or sono, ho avuto la fortuna di provare un sonar a scansione laterale di un amico titolare di un’azienda di lavori subacquei, il quale doveva tarare e collaudare una nuova unità trasmittente subacquea. Dovendo scegliere un relitto su cui effettuare i passaggi di prova, per verificare la qualità della scansione, la regolazione e il funzionamento dell’apparato, scelsi di andare sul relitto del "Washington", che non ero ancora riuscito a vedere bene nonostante tutte le mie ripetute immersioni. E così ho potuto finalmente farmi un’idea esatta dello stato di quella nave: anche se la scansione del sonar non è della massima qualità, a causa di alcuni problemi di taratura dello strumento, appare però evidente che la sezione di poppa è la più devastata a causa dei recuperi fatti a suo tempo dall"’Artiglio". La murata di dritta di fianco alla tuga centrale non esiste più e lo scafo appare, anche nel rilevamento sonar come un guscio vuoto.


In conclusione, non si tratta certo di un’immersione entusiasmante, soprattutto per la scarsissima visibilità, però il fascino che emana da quei poveri resti martoriati è intenso.
E i subacquei, specialmente se tecnici, sono un po’ masochisti…
Insomma, credo che sia inutile consigliare di non andarci. Però una cosa deve essere chiara: viste le condizioni ambientali sempre proibitive, le immersioni sul "Washington" devono essere fatte solo da gente molto esperta e allenata.
E sempre con molta prudenza.
Claudio Corti
(Per le foto d’epoca si ringraziano Franca e Giuseppe Viacava, eredi di Lorenzo Viacava)
Ringraziando Claudio Corti per l’articolo vi invitiamo a visitare il sito della TSA
E’ assolutamente vietata la riproduzione, anche parziale, del testo e delle foto presenti in questo articolo, senza il consenso dell’autore.
Autore: Claudio Corti
Il "WASHINGTON"
Oggetto di una campagna di recupero del famosissimo "ARTIGLIO", il bastimento si trova a 85 metri di profondità ed è ridotto ad un guscio vuoto che sporge da un fondo di fango, in un’acqua sempre caratterizzata da una scarsissima visibilità. Proveniva dagli Stati Uniti quando venne centrato dal siluro di un sommergibile tedesco.


Era la sera del 3 maggio 1917.
Un convoglio alleato stava transitando vicino alla costa, approssimativamente davanti a Camogli, in Liguria, e si stava dirigendo verso La Spezia. Un siluro lanciato da un sottomarino tedesco colpì una delle navi più grandi. Si trattava del piroscafo di 8.000 tonnellate "Washington", arrivato dagli Stati Uniti con un carico di materiale destinato alle Ferrovie Italiane. Qualche giorno prima, la nave aveva tentato di entrare nel porto di Savona, ma per qualche ragione burocratica, o semplicemente perchè lo scalo non aveva attrezzature adeguate allo scarico di quanto veniva trasportato, fu fatta proseguire per Livorno con un convoglio di altri bastimenti.
Il "Washington" fu colpito dal siluro a prua, sulla dritta, e affondò rapidamente, dopo essersi girato con la prora puntata verso il vicino abitato di Nervi. Affondò sempre di prua, sollevando tutta la poppa fuori dall’acqua, con la grande elica che girava ancora, come avevano raccontato alcuni testimoni. Tutto l’equipaggio riuscì a mettersi in salvo sulle scialuppe con due delle tre mascotte di bordo: due cagnolini. La terza, un gatto, si spaventò e corse a nascondersi. Quando Io cercarono, non lo trovarono. L’animaletto rimase a bordo, e seguì la sorte della nave su cui viveva.
Il punto in cui si trova il relitto di questa grossa nave è circa tre miglia al largo di Camogli, vicino a Punta Chiappa. Nel mese di agosto del 1987 mi trovavo proprio lì, con lo sguardo vigile, che seguiva la traccia dell’ecoscandaglio in attesa di vedere comparire sullo schermo dello strumento i resti dello scafo affondato. Volevo immergermi su quanto rimaneva del "Washington" con Damiano Grassi, un subacqueo che da alcuni anni mi accompagnava nelle avventure più profonde e aveva una bella e spaziosa barca offshore di 10 metri di lunghezza. Per questa immersione ci eravamo allenati in modo particolare. Ci era stato detto che la profondità massima che avremmo dovuto raggiungere sarebbe stata di 90 metri, a meno che di non avessimo avuto la fortuna, o l’abilità, di riuscire a pedagnare la parte più alta del relitto, la tuga centrale. Dato che non potevamo contare esclusivamente sulla buona sorte, ci eravamo abituati gradualmente, nel corso dell’estate, ad andare sempre più profondi, sino a raggiungere la quota desiderata. Eravamo partiti da 50 metri e avevamo man mano aumentato le profondità di 4 o 5 metri per volta, non di più. In quel periodo, da veri incoscienti, ci immergevamo ancora con l’aria, dato che le prime immersioni con le miscele Trimix le cominciai l’anno dopo, nel 1988. Io scendevo con sulle spalle un bibombola "made in France" composto da due bombole di 12 litri, gialle, mentre Damiano aveva un mono da 18,9 litri. Le bombole con l’aria di scorta le lasciavamo appese alla cima di risalita (non dovevamo assolutamente perderla). La permanenza sul fondo era veramente poca. Tutta la risalita e le tappe di decompressione erano affidate ai computer da polso, e come tabelle di emergenza avevamo quelle della U.S. Navy sino a 95 metri. Oggi le cose sono cambiate, ma in quegli anni operavamo in questo modo.
Le mie prime esperienze con il Trimix iniziarono l’anno successivo, dopo che mi resi conto che con l’aria, alle grandi profondità, la vita di un uomo era veramente appesa a un filo. O smettevo di andare così profondo, o avrei dovuto trovare qualche accorgimento per diminuire i rischi. Ogni volta che risalivo da un’immersione profonda ad aria, infatti, rivedevo il volto di mia moglie e dei miei due figli piccoli e ringraziavo il Signore di avermi concesso ancora una volta di essere così imprudente senza pagare alcun dazio. Mi resi conto, ben presto, che le miscele Trimix erano l’unica soluzione ai miei problemi. A farmele conoscere furono alcuni amici che avevo nel mondo del lavoro subacqueo, professionisti che operavano tutti ad alte profondità. Da allora, cioè da quando iniziai a usare il Trimix, non feci più immersioni ad aria oltre i 50 metri.
E oggi consiglio a tutti di scendere con il Trimix anche per andare "solo" a 50 metri. Sapevo che sul "Washington" avevano lavorato per tre anni consecutivi i palombari dell"’Artiglio", la prima nave della ditta So.Ri.Ma. (Società Ricuperi Marittimi) di Genova organizzata appositamente per i recuperi subacquei.


Tutte le notizie che avevo sulla sfortunata nave americana mi erano state fornite da un anziano pescatore di Camogli, Lorenzo Viacava, classe 1906. Lo chiamavano Napoli, perchè da giovane cantava con passione le più famose canzoni napoletane. E per più di cinque anni Viacava aveva lavorato come marinaio sull"’Artiglio". Ne aveva di cose da raccontare, il signor Lorenzo! Egli si ricordava benissimo, per esempio, che i lavori sul "Washington" erano iniziati nel 1926 e che i primi palombari che vi scesero furono tre tedeschi. Dopo un anno, però, i risultati delle enormi fatiche fatte erano molto scarsi. E ci si rese conto che quasi tutti i giorni i lavori dovevano essere sospesi per un motivo o per l’altro. Viacava ricordava che quando un palombaro tedesco scendeva sul fondo quasi subito si faceva recuperare, dicendo che l’acqua era troppo torbida, o che c’era troppa corrente, o che qualcosa non funzionava bene. Insomma, se non era questo, era quello! Però, a tavola, aggiungeva malizioso Napoli, stavano sempre volentieri, mangiavano di tutto in grandi quantità e non disdegnavano il buon vino. Insomma, mi è sembrato che quei tre non gli fossero particolarmente simpatici.


Visto che i lavori andavano troppo a rilento, al posto dei palombari tedeschi furono assunti tre palombari di Viareggio. E le cose cambiarono presto in meglio. Il notevole carico del "Washington", composto da 500 tonnellate di rame, 2.000 tonnellate di barre d’acciaio, sette locomotori ferroviari con relativi tender, sette caldaie e circa 300 vagoni, smontati ma completi, venne quasi totalmente recuperato. E venne recuperata pure l’elica del siluro tedesco che affondò la nave, tanto che ora è esposta nel museo marinaro di Camogli.
Per procedere al recupero della grande quantità di materiale, quelli dell"’Artiglio" utilizzavano cariche di esplosivo, che scoperchiarono completamente le stive. In questo modo il bastimento venne aperto come una scatola di sardine. Dopo che le lamiere della coperta erano state divelte, all’interno delle stive veniva calata una grossa benna, che un poco per volta riportava in superficie tutto quanto riusciva ad afferrare. Per il recupero di certi tipi di materiale, era molto efficace anche un grosso piatto magnetico, che funzionava come una gigantesca calamita.
Essendosi dimostrato poco efficiente lo scafandro tedesco Neufeldt & Kuhnke, che faceva parte della prima dotazione dell"’Artiglio", nei successivi tre anni di lavoro sul relitto del "Washington" furono sperimentati altri tipi di scafandri, finchè l’ingegner Luigi Faggian, uno dei fondatori e dei titolari della So.Ri.Ma., fece collaudare uno scafandro cilindrico a torretta, senza gambe nè braccia, ma con cinque oblò, dai quali per primo il palombaro Gianni, figura mitica in quell’ambiente duro e selezionato, poteva vedere in ogni direzione restando sospeso sopra il fondo: in qualunque direzione le correnti girassero la torretta, l’uomo che c’era dentro poteva vedere che cosa stava succedendo all’esterno e dirigere il lavoro della benna. Viacava si ricordava bene di tutti quelli della So.Ri.Ma., ma in particolare si ricordava dell’ingegner Faggian e del gruppo di palombari che lavorò sul "Washington", tra i quali l’Alberto Bargellini e il Gianni, tutti di Viareggio.
I palombari che lavorarono sul relitto del "Washington" e tutto l’equipaggio deIl"’Artiglio", che li assisteva, perirono alcuni anni più tardi in una tremenda deflagrazione che si verificò quando stavano smantellando un relitto carico di esplosivo vicino alle coste francesi nella Manica. Morirono tutti, tranne Lorenzo Viacava. Quella volta, si trattava di una missione all’estero, pagata meglio delle altre. Viacava non era stato chiamato a parteciparvi perchè era tra i più giovani. Alle spedizioni più remunerative, infatti, di solito andavano per consuetudine i più anziani. E così Viacava si salvò.

Ringraziando Claudio Corti per l’articolo vi invitiamo a visitare il sito della TSA
E’ assolutamente vietata la riproduzione, anche parziale, del testo e delle foto presenti in questo articolo, senza il consenso dell’autore.