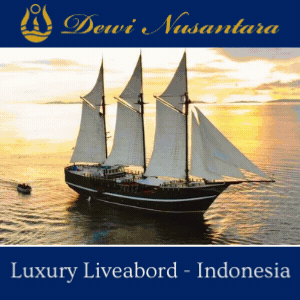Autore testo: Pierpaolo Montali
Autore foto: Mario Spagnoletti
Il giorno in cui Mario mi chiamò per dirmi che aveva avuto contatto con il Sindaco del Comune di Olgiate Molgora e che questi si fosse felicitato con lui per il suo interesse verso le Miniere di Marna abbandonate, sino al punto di omaggiarlo di una copia del libro che avevano editato sull’argomento, quasi trasalii.
Eravamo riusciti ad avere un canale diretto di informazioni su quella che oggi potrei definire un’autentica esclusiva ed allo stesso tempo un’opera fondamentale del nostro settore, compiuta con una dedizione ed una professionalità esemplari da alcuni speleo subacquei appassionati e di cui eravamo venuti a conoscenza per pura combinazione.
Si tratta di un complesso minerario dismesso sin dagli anni ‘cinquanta del secolo andato e poi dimenticato dalla memoria umana sino al punto che gli stessi abitanti di zona stentano e riconoscerne fattezze e reali dimensioni.

Le Gallerie Pelucchi del Cementificio del Fabbricone dei Fratelli Gnecchi, come veniva definito dai brianzoli di un tempo.
Alla fine di una serie di esami e di considerazioni trovammo il collegamento a colui che inconsapevolmente sarebbe divenuta la nostra guida in questa avventura e che ne era anche ed allo stesso tempo il suo maggior artefice: Matteo Bertulessi dei Sommozzatori di Almè di Bergamo.
Quando lo chiamai la prima volta al telefono mi presentai come un subacqueo che avrebbe avuto il desiderio di fare questa esperienza e di documentarla. Dopo avermi ascoltato con la sua consueta calma, che sembra alla prima volta quasi un distacco, mi rispose: “proviamoci”.
Matteo comunque ci disse che, prima di portarci a spasso per le gallerie, avrebbe voluto comunque conoscerci in un primo sopralluogo generico.
La sorte volle però che codesto passaggio fosse ridotto al minimo indispensabile: tra maggio e giugno del 2010 infatti le piogge caddero insistenti, rendendo difficoltosa la nostra possibilità di accesso agli ànditi allagati della miniera abbandonata.
La richiesta della nostra guida fu poi quella di compiere l’immersione esclusivamente con circuiti aperti, poiché l’ingresso in acqua si sarebbe dovuto fare calando se stessi e l’ attrezzatura da uno stretto pozzo di collegamento tra il primo ed il secondo livello delle gallerie, che, pur modificato com’era, non avrebbe consentito il passaggio di delicate apparecchiature elettroniche con la assoluta sicurezza in modo che non riportassero danni. Io in particolare quindi rinunciai al mio fidato rebreather, accettando di buon grado la sensata indicazione.

La prima volta che si entra nelle gallerie del primo livello, che è aereo, si ha la percezione dell’enormità e se poi la si correla all’idea degli strumenti che si potevano avere a disposizione per il lavoro sino a metà del secolo andato, vien così subito da pensare alle straordinarie fatica e dedizione di coloro che ci lavorano all’interno.
Il primo livello è normalmente soltanto in parte allagato, ma con la caduta insistente delle piogge esso tracima per spinta consistente dal basso.
Il sentore che si ha, entrandoci nei mesi caldi, è il fresco che investe il visitatore: là dentro infatti regnano sovrani ed incontrastati i 17 gradi centigradi aerei. Matteo racconta addirittura di un anziano del paese, che ritrovavano spesso all’ingresso delle Pelucchi, le prime volte che entravano per esplorarle nel 2002-2003, seduto il pomeriggio su una seggiola di plastica, proprio negli afosi mesi estivi, con il giornale in mano ed intento a leggerselo godendo del fresco proveniente da dietro il cancello di chiusura delle gallerie.
Il giro della parte di superficie non è certo meno interessante di quello che si affronta sott’acqua: frane di materiale di risulta, tracce dei binari della decauville che trasportava all’esterno delle miniere la marna faticosamente estratta, la colonna che divide i due rami di estrazione, di cui uno più grande dell’altro, con le tracce dell’immagine ora rimossa della protettrice di sempre dei minatori (S. Barbara), il ritrovamento straordinario di quelli che i geologi chiamano tecnicamente “pisoliti”, vale a dire formazioni calcaree che si creano solitamente in centinaia di anni per rotolamento di materiale intorno ad un granello di sabbia iniziale sino a creare una sorta di pallina da ping pong ed infine i chirotteri o pipistrelli, che qui hanno una caratteristica unica in Europa.


A circa 3-400 metri dall’ingresso si possono infatti trovare appesi alle grandissime volte (nel periodo invernale del loro letargo ed in generale di giorno negli altri mesi) esemplari di Myotis Capaccini e Myotis Nattereri: la singolarità della colonia presente nelle gallerie Pelucchi sta nel fatto che si tratti di due specie a grave rischio di estinzione e che sono nell’elenco dell’allegato della IV Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi naturali della flora e della fauna selvatiche.
Un po’ di storia
La produzione del cemento in Lombardia vanta una tradizione secolare: i primi studi sulle caratteristiche chimico-strutturali del materiale, eseguiti da tecnici francesi ed inglesi, risalgono infatti a fine ‘Settecento primi dell’Ottocento. Nel 1824 infatti viene registrato il brevetto del “Portland Naturale”, così definito per la colorazione tipica assunta dalla marna macinata, post cottura in alto forno a 1.400 gradi centigradi, che sembrava identico a quello della pietra dell’isola di Portland sulla costa meridionale britannica.
Vent’anni dopo la registrazione del “Portland Artificiale” invece, con migliorate performances di resistenza alla trazione ed alla compressione.
In Italia la tecnologia industriale arrivò intorno al 1.860 e tra le aree più attive vi fu senza dubbio la provincia di Bergamo, favorita dalla sua strategica posizione a metà tra la catena delle Prealpi, ricca di miniere, e la Pianura Padana con grandi arterie stradali di scorrimento delle merci oltre che di corsi d’acqua. Del 1.878 fu la costruzione del cementificio dei F.lli Pesenti ad Alzano Lombardo, capostipite di una serie di stabilimenti,che, nel 1926, ne vantava 28 in tutto il territorio nazionale con 14 uffici di vendita di cui uno addirittura a Buenos Aires in Argentina.
Per meglio inquadrare la nascita del cementificio oggetto del nostro interesse occorre ripensare al grande impulso dell’industria nel lecchese ai primi del novecento, allorquando gli addetti erano divenuti il 45,81% contro il 39,33% dell’agricoltura, in controtendenza rispetto alla più vasta area del Paese. Meccanica e metallurgia divennero simbolo della zona tanto quanto la lavorazione dei minerali e l’industria estrattiva.
Parallelamente anche l’industria chimico-pirica e lo sviluppo delle quattro banche locali costituirono il substrato per la nascita, nel 1906, quando i fratelli Gnecchi, già titolari delle cave di Maggianico, decisero di chiedere il permesso di sfruttare i giacimenti di marne nelle zone collinari tra San Zeno e Santa Maria Hoè; cioè in area dell’attuale Comune di Olgiate Molgora.

L’attività estrattiva della famiglia datava addirittura al mille e cinquecento circa e, forti di una tale esperienza, essi costituirono così una società: la Ditta Gnecchi & C.
I Fratelli sapevano che quell’area avrebbe goduto di svariati vantaggi: era collocata a ridosso dello scalo merci ferroviario di Olgiate Molgora, sulla linea Lecco-Milano e poi era una località strategicamente decentrata dalle altre produzioni concorrenti di zona. La superficie interessata era una piana triangolare di circa diecimila metri quadri nel cuore della zona mineraria ai piedi dell’Ombrellino e poco distante dalla Cepera sulla collina tra Monticello e Alduno.
La costruzione del Fabbricone terminò nel 1908, anno in cui partì anche la produzione del cemento Portland Naturale, per via del fatto che il banco di marna scavato era molto puro.
I forni furono in tutto sei e vennero costruiti con materiali refrattari giunti via mare dall’Inghilterra sino a Genova, così come il carbone bruciato per alimentarne il calore, mentre la restante attrezzatura fu fornita dall’industria tedesca.
Nel 1.912 la profonda crisi finanziaria non impedì alla banca di Lecco di recedere dai propri impegni finanziari e costringere così i fratelli Gnecchi e vendere la fabbrica del cemento al gruppo dei Fratelli Pesenti, principali azionisti della Società Anonima Italiana Cementi di Bergamo.
Il Fabbricone arrivò nella sua storia a produrre sino a 40-50.000 tonnellate di cemento all’anno partendo da 70.000 di pietra grezza, ma ciononostante non riuscì a reggere alla crisi pre-bellica della seconda guerra mondiale, subendo la concorrenza delle nuove cementerie di zona, più efficienti dal punto di vista produttivo ed energetico.
L’edificazione ed il funzionamento del cementificio produsse poi in zona anche un grave problema ambientale: di suoi camini usciva costantemente del fumo bianco carico di micro polveri di cottura. Il passaggio in zona dei cosiddetti vapurén, i piccoli convogli a vapore della ferrovia dècauville, producevano altro fumo ed un fragore mal sopportato.
Nel 1.941 così l’Italcementi decise di interrompere la produzione all’interno del Fabbricone e nelle relative miniere adiacenti. Tale decisione fu resa ancor più motivata dalla difficoltà nell’approvvigionamento di carbone proveniente dall’Inghilterra per via degli embarghi strategici.
Durante lo svolgimento del conflitto le gallerie, ormai sgomberate dagli operai, vennero utilizzate come deposito per parte della produzione strategica della Pirelli, che trovò così valido rifugio dai bombardamenti alleati.
Dopo la guerra una serie di rimpalli tra proprietà e pubbliche autorità diedero alla popolazione locale, stremata dalla mancanza di lavoro, la sensazione che si potesse riprendere anche aprendo nuovi rami estrattivi; ma alla fine tutto tacque e cave e cementificio furono definitivamente dismessi il primo giugno del 1955, allorquando decadde la concessione di sfruttamento minerario.
Parte delle gallerie furono in seguito ripristinate e riutilizzate come fabbrica di smaltimento del legno e di produzione della segatura sino al 1.967, anno in cui, il 3 giugno, si verificò una tremenda esplosione con sviluppo di un grosso incendio che provocò la morte di sei persone.
I lavori di rimozione dalle gallerie della ferrovia dècauville, che terminarono nel 1.952, portarono invece via tutti i materiali e le attrezzature metalliche in dotazione (perforatrici, montacarichi, corde metalliche ed utensili vari), poiché dopo il conflitto il poco metallo disponibile e di recupero acquisì un valore di mercato importantissimo.
Il recupero storico ambientale e le esplorazioni subacquee
Nel 2002 Matteo Bertulessi, Luigi Rota e gli amici Sommozzatori di Almè di Bergamo, che sanno dell’esistenza di un vecchio complesso minerario abbandonato in zona, decidono di mettersi attivamente alla sua ricerca, anche contro l’apparente e sonnacchiosa incredulità locale.
In quest’opera trovano la validissima collaborazione della Giunta Comunale, che crede nel loro progetto e lo asseconda al fine di ottenere anche i relativi permessi di accesso.
Quando entrano per la prima volta dal portone che sbarrava ormai da anni l’accesso alle gallerie Pelucchi sono obbligati a farsi strada tra ogni sorta di rifiuto ed ingombro, sino a ridare luce a quella che oggi è considerabile la via di accesso alle immersioni sotterranee.
Nell’autunno del 2002 iniziarono le esplorazioni subacquee vere e proprie con la circospezione del caso e tra lo scetticismo anche di esperti del settore speleo subacqueo, poiché alcuni di essi ritennero che gli evidenti crolli potessero compromettere la sicurezza dei luoghi, ritirandosi dall’iniziativa per tale motivo.
In realtà non era così e da allora ad oggi, la caparbietà di Matteo e dei suoi amici, in più di duecento immersioni hanno consentito di enumerare le seguenti cifre:
700 ore complessive di immersione
tre chilometri e mezzo di sagole segna-percorso svolte e piazzate
2 milioni di litri di aria circa consumati in immersione
150 mila litri di ossigeno puro consumati per le fasi decompressive
Si chiamarono esperti del Politecnico di Torino e di Milano nell’eventuale ipotesi futura di porre in completa sicurezza gli ambienti aerei e di recuperarli alla visita educativa di scolaresche e turisti; ma i costi complessivi dell’operazione bloccarono l’iniziativa.
Identica collaborazione universitaria si sviluppò nella ricerca, identificazione e classificazione delle due specie di chirotteri presenti sul fondo delle gallerie grazie anche al valido contributo di altre associazioni specialistiche.
Le esplorazioni subacquee invece procedettero una per volta per i cinque gradi di livello dalla superficie al suo fondo che la miniera presentava: dagli otto sino ai meno settantaquattro metri registrati in immersione con massima piena.
Le gallerie di scavo si sviluppano anche per qualche centinaio di metri a destra ed a sinistra del pozzo principale di discesa che le interconnette.
Si può così affermare ora, con cognizione di causa, che sotto Olgiate Molgora vi sia un autentico lago sotterraneo.
Le immersioni
Si decise così che i primi ad entrare nei Labirinti Sommersi saremmo io e Mario con Matteo che ci guidava alla esplorazione dei primi quattro livelli delle gallerie.
Sabato mattina primo maggio, indossati i pesantissimi sotto muta invernali da acque gelide e le mute stagne, assemblati erogatori e bibombola ai gav, preparate le bombole di fase e di eventuale emergenza, ci caliamo nello stretto pozzo che divide i primi due livelli prima di persona. A seguire le attrezzature che ci vengono fatte arrivare in basso dagli amici Sergio e Gian Piero con l’utilizzo del grosso argano arrugginito, ma pur sempre valido, recuperato dall’epoca.
Gli ultimi preparativi e controlli vengono effettuati sui gradini della rampe semi sommerse nel laghetto sotterraneo con l’ausilio di Gherardo, Giorgio e Stefano, che ci hanno seguiti in questa avventura fuori dal tempo e per certi versi anche dal mondo.
La prima sensazione che ho quando metto la testa nell’acqua è quella del buio assoluto, forse più buio di quello che ho fino ad oggi incontrato nei miei laghi anche in giro per l’Europa.
Accendo i potenti illuminatori a led Styled; tutto cambia.

Un mondo che riconosco come modificato dall’opera dell’uomo mi si dispiega parzialmente davanti e, l’invito ad avanzare che mi viene dai cenni di Matteo, mi incoraggia ancor più a proseguire nella discesa lungo il pozzo principale che, dal secondo livello, scende dritto sino al quinto, il più profondo.
Noto subito la meticolosità e la solidità della tracciatura della sagole che le mie guide hanno piazzato in otto anni di pazienti e silenziose immersioni: anche toccandole infatti esse sembrano resistenti e ben fisse ai loro appigli, stanti le difficoltà di cui mi accennava prima dell’immersione Matteo, nel reperirne di validi. Ogni sosta di livello poi ha il suo numero chiaramente indicato con un cartello.
L’immersione prosegue in un’acqua fredda, ma comunque costante a 11 gradi, cosa che sinceramente non mi aspettavo: l’acqua delle gallerie Pelucchi infatti è di infiltrazione e di risorgenza, viene dalle profondità del sottosuolo e da quei passaggi che forse neanche agli speleo subacquei sono così chiaramente noti a volte, rendendo così motivate le loro esplorazioni.
Io sono un profano, ben determinato, ma comunque non uso a questi ambienti: ecco perchè, mentre scendo, cerco di fare attenzione ad ogni singolo dettaglio, ad ogni cambio di direzione, ad ogni indicazione sulle sagole.


Arriviamo sino alla strettoia del quarto livello di profondità, ove la galleria si restringe dopo circa un centonovanta di metri di avanzamento orizzontale: ci troviamo ora davanti al probabile collegamento con le altre gallerie sorelle (le Valicelli), che la documentazione riporta e che però nessuno ha mai ufficialmente trovato.
Matteo dà le disposizioni con cenni comprensibili: “Mario, con la macchina fotografica avanzi, tu resti fuori”. Il fotografo parte e sparisce al di là della franata nella strettoia della galleria, che si distingue nitidamente sulla destra dell’ingresso; vedo solo più le loro luci di riflesso tra la polvere inevitabilmente sollevata.
Ora sono solo in ambiente chiuso e buio e senza conoscenza diretta della via, fatta eccezione per la sagola che non smetto mai di guardare, illuminata dalle mie potenti luci a led. Mentre attendo penso a come potrei fare se i due non tornassero indietro: del resto io non so ancora che i metri che ci separano realisticamente son soltanto una decina.
Improvvisamente un tremolio sembra muovere tutto; il mio primo pensiero, dopo aver visto cadere frammenti dalla volta è: “ho toccato qualcosa….le mie bolle distaccano pezzi dal soffitto! Mannaggia, avessi avuto il mio reb!!”. Poi la caduta sembra finire ed io mi rassereno.

All’uscita Matteo mi spiegherà che si è trattato di un treno, passato in superficie proprio nei pressi delle gallerie come cent’anni fa e che ha così provocato qualche movimento di caduta nel sottosuolo allagato.
L’immersione prosegue con il cenno di Mario, sbucato fuori dal nulla, che mi invita ad entrare dopo la sua sequenza fotografica.
Procedo con cautela cercando di volare in assetto perfetto per non alzare altra polvere.
Vedo la congiunzione della due gallerie di mina ed il punto in cui sembrano chiuse artificialmente dal lavoro dell’uomo con un’opera che somiglia ad una sorta di surreale caminetto domestico e subacqueo.
Al rientro, dopo aver percorso tutta la galleria sagolata, sarà una escalation di scatti sul pozzo centrale in risalita, ove vedremo la tabella decompressiva da lavoro che i sommozzatori si son lasciata fissa sul percorso ormai da anni, ad uso di ogni emergenza strumentale e la pompa ad immersione dell’acquedotto locale, che captava l’acqua che poi finiva regolarmente nelle case degli abitanti di zona sino alla metà anni ‘ottanta.
All’uscita dal pozzo aereo tra il secondo ed il primo livello di gallerie, dopo aver riportato tutto in superficie, sembra davvero di rinascere, colpiti dalla luce del sole e dalla temperatura superiore a quella dell’interno.

Non sono così abituato agli ambienti ipogei e questa sensazione perciò mi stimola particolarmente.
Trascorreranno altre due settimane di piogge quasi monsoniche prima di poter rientrare in miniera per la seconda parte della spedizione con acqua decentemente visibile. Nel contempo Matteo, durante un sopralluogo all’interno delle cavità, ci invierà via mail una foto in cui si vede l’acqua lattiginosa che fuoriesce dal pozzo attraverso cui siamo passati per raggiungere il laghetto sotterraneo e con la scala a pioli completamente sommersa; anche il primo livello dunque finisce sott’acqua, sia pur di qualche centimetro.
Torneremo in giugno con Ghery e Giorgio, gli atri componenti dello Styled Team Explorer, per completare questa esplorazione documentale.
Ad attenderci questa volta anche Luigi, il “socio” di Matteo, con i fidati Sergio e Gian Piero ad aiutarci come portatori e senza i quali tutto sarebbe vano: questa volta caleremo nel pozzo anche i due pesanti 15+15 di Giorgio e Ghery, più i 12+12 mio e di Mario e le consuete relative bombole relé (due sette litri ed un undici litri per ciascuno).
Io mi porterò dietro tutto, senza lasciar sul pozzo di discesa nessuna bombola, poiché oggi si prevede l’esplorazione del quinto livello, che dovrebbe essere compreso fra i 60 ed i 74 metri dall’ingresso sul piano di campagna e dunque preferisco faticare di più, ma non derogare alla necessità di sicurezza da imprevisto.
La pianificazione prevede che Matteo, Mario ed io si scenda per primi con la macchina fotografica e dopo seguano Luigi, Giorgio e Ghery, con la microcamera da riprese in full HD montata sul casco; le nostre due strade saranno forzatamente differenti, a causa dell’acqua non troppo pulita e della possibilità di sporcarla vicendevolmente.
Elisa ci aiuta facendo le fotografie di superficie, tutti gli altri fan passamano con le attrezzature.
La preparazione mia e di Mario scivola via facile e meticolosa come sempre, attendendo Matteo che è andato a verificare la tenuta alla piena delle sagole di partenza: quando egli riemerge con il classico segnale di ok ci si schiarisce il viso.
Scendiamo dalle scale subacquee, affrontiamo la prima sosta all’imbocco del pozzo centrale subacqueo e fissiamo la bombola di ossigeno di Mario, che così è più libero nel brandeggio della apparecchiatura fotografica.
Dopo un cenno di ok inizia il viaggio nel baratro, passando a fianco la scala passamano in metallo sulla destra prima e poi a quella ricavata dal taglio nella roccia viva dopo.
Siamo al quarto livello, a quota meno quarantacinque circa, Matteo indica il passaggio verso il quinto livello: un cenno d’intesa e si prosegue.
Scendiamo sino al livello più profondo; la pianificazione prevede che si faccia un tratto in orizzontale di una quarantina di metri sino ad arrivare ad una scala verticale che lo collega al quarto, passaggio questo che veniva utilizzato dagli operai durante le loro faticose discese in miniera per i lunghi e faticosi turni di lavoro e che ora noi ripercorreremo dopo quasi sessant’anni.
Siamo quasi a sessanta metri di profondità sottoterra in un buco allagato e, mente percorriamo nuotando lo sviluppo della galleria, noto le orme degli stivali dei minatori riconoscibili sul fondo argilloso prima di giungere alla strettoia della scaletta che collegava i due livelli sovrapposti.
E’ quasi come se il tempo avesse fermato un gesto, come se mi trovassi di fronte all’orma fossile di un animale preistorico in una caverna, invece è un passo dell’uomo, una sorta di firma della sua fatica.
Lascio quindi passare Mario nello stretto passaggio, restando ultimo, poiché mi accorgo che la visibilità sta calando ed egli non potrebbe più fotografare dopo il mio transito carico dei pesi e degli ingombri che mi sto trasportando.
All’uscita dal pozzo di collegamento non vedo quasi nulla se non volgendo lo sguardo verso la mia sinistra alla ricerca di riferimenti: la luce spara sulla sospensione e Matteo, davanti a noi girato a controllare che seguiamo, impalla con la sua il mio sguardo.
Seguitiamo ad andare verso sinistra e dopo un po’ raggiungiamo il collegamento con il pozzo centrale. Da qui è prevista la salita al terzo e l’esplorazione del tratto di destra con altro passaggio a strettoia, che però non faremo, per lasciarlo pulito agli altri.
All’interno della galleria del terzo livello si trova la maggior quantità di manufatti: dalle scale a pioli infissi nella roccia viva, sino alla punta di un martello pneumatico lasciata nel foro che stava perforando, forse perché impossibile da estrarre, ai sostegni in ceramica del vecchio impianto elettrico, a cui l’ottima nostra guida ha fissato le sagole guida.
Ci riportiamo lentamente al pozzo centrale ed incrociamo i nostri tre amici che scendono per il loro giro sulla linea del quarto e terzo livello. Un rapido cenno d’intesa ed essi scompaiono a destra nella galleria del piano di sotto (si fa per dire!).
Riemergendo si ha modo di notare la casetta di ricovero attrezzi che c’è sul lato scala, la grande vasca tramoggia di scarico delle marne, intricata di cavi e che Matteo ci dice essere stata coperta da una grande rete poi caduta durante una delle loro esplorazioni.
Arriviamo al secondo livello dopo aver fotografato alcune connessioni elettriche e recuperiamo la bombola di ossigeno lasciata in partenza; qui Mario, mentre si prepara a riagganciarla, mi passa la macchina fotografica. Comprendo al volo: non vuole perdere l’occasione di avere, anche lui, una sua foto; mi pare più che giusto, in fondo lui non c’è mai, stando dall’altra parte dell’obiettivo. Mi fa vedere il leveraggio di scatto e mi fa cenno di tirare.
Non sono un fotografo del suo livello e quindi tiro diversi scatti: “nel numero farò la sostanza” penso. I fatti mi daran ragione in seguito quando all’uscita nel mondo “normale” riguarderemo le foto ed al termine dei 82 minuti in immersione della seconda sequenza di sommozzatori.
Un ringraziamento è ora doveroso a Matteo ed a tutti gli amici bergamaschi, oltre che i miei compagni di immersione, consapevole di aver vissuto un’altra esperienza unica ed assolutamente sui generis.
È assolutamente vietata la riproduzione, anche parziale, del testo presente in questo articolo senza il consenso dell’autore.